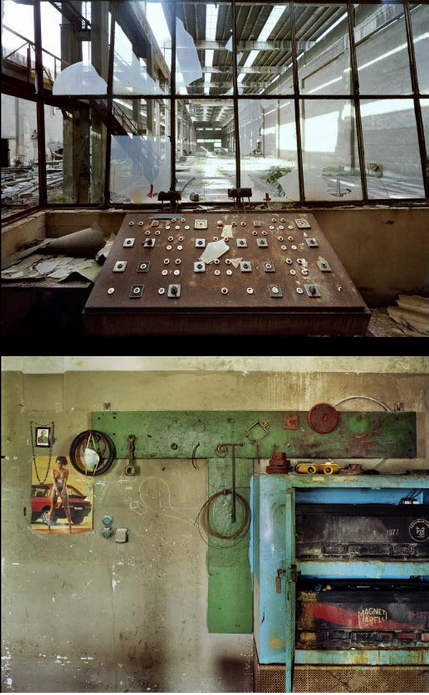Il giorno che mi hanno deportato in Honduras è iniziato un incubo, a causa dei miei tatuaggi. Li avevo fatti negli Stati Uniti ma in centro America infastidivano i pandilleros”. Evelyn ha 27 anni ed ora che ha ottenuto la protezione complementare in Messico (una protezione prevista per chi non può tornare nel proprio Paese), con l’assistenza dell’Unhcr, vuole raccontare come la violenza delle maras – i gruppi armati legati al narcotraffico e alla criminalità – possa essere arbitraria e non lasciare altra possibilità che la fuga.
 Ci parla da una fattoria messicana, la giornata di lavoro deve ancora iniziare, lei lavorerà ma senza esagerare perché è incinta della terza figlia. Evelyn è partita per gli Stati Uniti giovanissima e vi è rimasta dieci anni, un lungo periodo di vita clandestina in cui si guadagnava da vivere tra ristoranti e fattorie. Ed è in territorio Usa che si è fatta numerosi tatuaggi perché le piacevano e perché lì era la moda: fiori colorati sulle spalle e sui fianchi e i nomi delle sue bambine. Ma un giorno una collega la denuncia, sa che Evelyn non ha i documenti in regola e le fa pagare una lite con una telefonata alla polizia che la porterà in un centro di detenzione per migranti. “Non saprei dire quanto ci sono rimasta, mi hanno liberato perché avevo una bambina a carico” racconta Evelyn. Poi alla scarcerazione è seguito la deportazione in Honduras, il Paese dove era nata. L’Honduras è al primo posto, nel mondo, per il numero di omicidi: 57,3 persone ogni 100mila abitanti muoiono di morte violenta. La media nel resto del pianeta è 6,2. La ragazza era ospite della sorella a San Pedro Sula, non lontano dal confine guatemalteco, ma dopo soli cinque giorni è stata rapita. “Ero in un negozio, sono arrivati due uomini, mi hanno sollevato e caricato su una macchina, all’inizio non capivo, mi tempestavano di domande sui miei tatuaggi”. Le maras del Centro America – le più importanti sono la Pandilla Barrio 18 e la Mara Savatrucha MS 13 – usano i tatuaggi come segno distintivo e di appartenenza, ogni disegno ha un significato legato all’iniziazione o alle attività criminali e i capi possono tatuarsi anche il volto. “I miei tatuaggi li disorientavano, alcuni avevano colori appartenenti a maras nemiche, ad un certo punto hanno pensato che fossi la donna di più capi allo stesso momento”. Durante il sequestro Evelyn ha subito diverse forme di violenza che non vuole ricordare, “continuavano a chiedermi il significato dei miei tatuaggi e mi ripetevano: ‘possibile che nessuno ti abbia spiegato che non puoi avere questi colori insieme?’”. Poi è stata liberata: “non so perché, se io li abbia convinti delle mia totale estraneità da quel mondo, se lo abbia voluto Dio o se li ho impietositi parlandogli delle mie bambine”.
Ci parla da una fattoria messicana, la giornata di lavoro deve ancora iniziare, lei lavorerà ma senza esagerare perché è incinta della terza figlia. Evelyn è partita per gli Stati Uniti giovanissima e vi è rimasta dieci anni, un lungo periodo di vita clandestina in cui si guadagnava da vivere tra ristoranti e fattorie. Ed è in territorio Usa che si è fatta numerosi tatuaggi perché le piacevano e perché lì era la moda: fiori colorati sulle spalle e sui fianchi e i nomi delle sue bambine. Ma un giorno una collega la denuncia, sa che Evelyn non ha i documenti in regola e le fa pagare una lite con una telefonata alla polizia che la porterà in un centro di detenzione per migranti. “Non saprei dire quanto ci sono rimasta, mi hanno liberato perché avevo una bambina a carico” racconta Evelyn. Poi alla scarcerazione è seguito la deportazione in Honduras, il Paese dove era nata. L’Honduras è al primo posto, nel mondo, per il numero di omicidi: 57,3 persone ogni 100mila abitanti muoiono di morte violenta. La media nel resto del pianeta è 6,2. La ragazza era ospite della sorella a San Pedro Sula, non lontano dal confine guatemalteco, ma dopo soli cinque giorni è stata rapita. “Ero in un negozio, sono arrivati due uomini, mi hanno sollevato e caricato su una macchina, all’inizio non capivo, mi tempestavano di domande sui miei tatuaggi”. Le maras del Centro America – le più importanti sono la Pandilla Barrio 18 e la Mara Savatrucha MS 13 – usano i tatuaggi come segno distintivo e di appartenenza, ogni disegno ha un significato legato all’iniziazione o alle attività criminali e i capi possono tatuarsi anche il volto. “I miei tatuaggi li disorientavano, alcuni avevano colori appartenenti a maras nemiche, ad un certo punto hanno pensato che fossi la donna di più capi allo stesso momento”. Durante il sequestro Evelyn ha subito diverse forme di violenza che non vuole ricordare, “continuavano a chiedermi il significato dei miei tatuaggi e mi ripetevano: ‘possibile che nessuno ti abbia spiegato che non puoi avere questi colori insieme?’”. Poi è stata liberata: “non so perché, se io li abbia convinti delle mia totale estraneità da quel mondo, se lo abbia voluto Dio o se li ho impietositi parlandogli delle mie bambine”.
La storia di Evelyn racconta la fuga che sempre più donne centroamericane affrontano per sottrarsi alla violenza: nel 2015 le organizzazioni stimano quasi 76.000 deportazioni tra uomini, donne e minori in Honduras, 50.000 donne se si prendono in considerazione i tre paesi del “Triangolo del Norte”. Da Salvador, Guatemale e Honduras infatti, le domande di asilo verso gli Stati Uniti nel 2014 hanno oltrepassato le 40.000 ma la protezione viene chiesta anche in Messico e nei Paesi vicini: dal 2008 ad oggi il numero di richieste nei Paesi confinanti si è moltiplicato per tredici. “Women on the run”, un report a cura dell’Unhcr, riporta le esperienze delle donne in fuga, la loro sfiducia nelle forze dell’ordine, le minacce che le seguono anche se cambiano provincia di residenza e la violenza fisica e psicologica. Sono spesso le stesse maras a imporre la scelta: o la morte o la fuga e così nel giro di poche ore si scompare spesso insieme ai propri bambini. Si diventa l’obiettivo dei pandilleros per ragioni diverse: una donna può essere desiderata da uno dei componenti, i giovanissimi vengono scelti come reclute, informatori o tuttofare a partire dai sei anni. E se non vogliono unirsi vivranno costantemente minacciati. Come accade ai negozianti, agli autisti di autobus e a chiunque abbia un’attività, la pandilla reclama la “cuota”, il pizzo, e se non si paga si viene perseguitati, spesso i propri cari vengono uccisi come forma di punizione. La “tassa di guerra” è un’estorisione che colpisce tutti: le donne che vendono tortillas di mais per strada, i tassisti e chi ha parenti negli Stati Uniti che inviano denaro a casa, le maras lo sanno e pretendono la loro parte.
Evelyn sta avviando la procedura per ricongiungersi con la sua prima figlia che vive ancora in Honduras e conclude il suo racconto con un appello: “Cercate aiuto, nei rifugi vicino ai confini ci sono cartelli con nomi di associazioni e numeri di telefono, chiamate e non rimante in silenzio perché uscire da quell’inferno ed essere protette è un vostro diritto”.
Pubblicato il 24 maggio su Repubblica.it