Classe ’88, autodidatta, Leonardo Crudi “espone” per le vie di Roma i suoi manifesti che raccontano le storie di chi ha provato a cambiare il mondo attraverso l’arte
Dal writing alla bic, dai muri dipinti a quelli ricoperti da un poster. Leonardo Crudi, classe ’88, è un artista romano che ha attirato il nostro occhio con due locandine dedicate ad Amore tossico, film cult di Caligari, attaccate in via Castro Pretorio. E poi ecco comparirne altre lungo la Nomentana e in altre zone della città. «Una volta terminato un manifesto, giro per Roma alla ricerca del posto giusto dove affiggerlo. Mi faccio un sacco di belle passeggiate…» conferma Crudi.

I poster tra forme e storia
Un segno e una composizione che cattura l’occhio ma non solo. In ogni poster c’è un volto – che sia quello di un attore o delle personalità dell’avanguardia russa – una storia, una parentesi di rivoluzione o sperimentazione che fa domandare allo spettatore: «chi è quello?» oppure riconoscerlo. Penna a sfera usata come una mina sottile che si muove in verticale, smalti per riempire di colore uniforme la geometria. Forma e contenuto contribuiscono a stimolare quella riflessione intellettuale teorizzata da Ėjzenštejn, il cosiddetto montaggio delle meraviglie, che infatti Crudi studia e approfondisce. L’artista deve cambiare il mondo, a provarci sono state le avanguardie: Suprematismo, Costruttivismo e Futurismo russo, l’artista rielabora le lezioni di Rodčenko, El Lissitzky e Malevič.
 Leonardo Crudi di fronte al manifesto Popova, affisso in piazza Orazio Giustiniani
Leonardo Crudi di fronte al manifesto Popova, affisso in piazza Orazio Giustiniani
Rivoluzione
Per il centenario della Rivoluzione d’Ottobre – 7 novembre 2017 – Crudi ha ideato un progetto di arte pubblica: manifesti, dipinti, disegnati a mano che si rifanno alla cartellonistica d’avanguardia sovietica. Contenuti politici esposti sui muri, per arrivare a tutti. Poco importa se il sole li scolora e qualcuno pensa di staccarlo e metterlo in soggiorno. Un messaggio politico che però poi si stempera nell’arte, nella manualità e non serialità dell’opera. Verrebbe da dire che è solo un ammiccamento al politico per poi ribattere – a se stessi, in un dialogo di autosmascheramenti – che l’arte e la cultura sono politica.
Cinema
Alla fine del 2017 arriva il progetto Cinema: locandine per le avanguardie cinematografiche o per quei film che non hanno avuto locandine perché fuori dai circuiti di promozione. Anche questi sono affissi in strada, illudendoci per un secondo che quel film sconosciuto che però tanto ci era piaciuto sia stato accolto in un cinema, magari un d’essai, e riproposto.
Intervista a Leonardo Crudi
Abbiamo fatto qualche domanda a Leonardo Crudi. E se già avete voglia di scoprirlo, cercate i suoi poster all’Outdoor Festival.
Il poster era considerato, nella classificazione tradizionale, un’arte minore eppure nella sua potenzialità espressiva è funzionale a tutte le arti. Perché hai scelto questo supporto?
«Ho iniziato a dipingere manifesti alla fine del 2016, in vista del centenario della Rivoluzione russa, che si sarebbe celebrato il 7 novembre 2017. Il manifesto è stato lo strumento propagandistico rivoluzionario per eccellenza. Artisti d’avanguardia, come Aleksandr Rodčenko ed El Lisickij, hanno realizzato poster a sostegno della Rivoluzione. Sono rimasto affascinato dalla grafica sovietica degli anni ’20 e mi è sembrato coerente utilizzare il manifesto, strumento di comunicazione dell’epoca rivoluzionaria, per realizzare opere dedicate al centenario e alle più importanti personalità, intellettuali e artistiche, dell’avanguardia russa (Ljubov’ Popova, Vladimir Majakovskij, Sergej Ėjzenštejn, etc.). C’è quindi uno stretto legame tra i temi delle mie opere e il supporto che impiego».
Come scegli i tuoi poster da attaccare per la città? Ogni quanto lo fai? Ti piace metterne in risalto la temporalità: il poster lentamente si consuma, si sporca, magari viene strappato…
«Dipingo manifesti destinati esclusivamente ai muri della città. Uso la carta da modello – quella dei sarti, per intenderci -, gli smalti, la penna bic o le matite. Una volta terminato un manifesto, giro per Roma alla ricerca del posto giusto dove affiggerlo. Mi faccio un sacco di belle passeggiate… Naturalmente, una volta affisso in strada, il manifesto è in balia delle intemperie atmosferiche e non solo. Il sole, ad esempio, dopo un po’ sbiadisce l’inchiostro della bic, con cui disegno i volti. Poi c’è chi prova a strapparlo dal muro, per portarselo a casa: non ci riesce e lo lascia mutilo di alcune parti. Ma non mi lamento, il decorso di un’opera nel contesto urbano è questo, se si rovina o te la strappano ci sta. Se non ho mostre da preparare, riesco a fare 2 poster a settimana, e per il momento sono tutti dedicati al progetto Cinema».
Il tuo orizzonte artistico varca i confini italiani ma qual è il tuo rapporto con Roma, sia come città da vivere e in cui lavorare che come ispirazione artistica?
«Conosco Roma grazie alla mia precedente attività di graffitaro. Dall’adolescenza fino ai 22 anni ho vissuto di notte in giro per le strade della capitale. Posso dire di aver viaggiato per Roma… L’ho visitata tutta, frequentando molto le periferie. Per quanto riguarda l’influenza culturale della città sulle mie opere, mi vengono in mente gli artisti della Pop Art romana, in particolare Renato Mambor, e i registi del cinema neorealista e d’avanguardia italiano, che hanno vissuto e lavorato, per la maggior parte, qui a Roma. Ho contaminato queste influenze con lo studio delle avanguardie russe. Così nasce il mio lavoro».
Il progetto “cinema” ha una valenza anche politica, dare spazio e visibilità a film non main stream che non hanno mai avuto “l’onore” di una locandina. Tra questi hai scelto Caligari, cosa ti ha colpito dei suoi film? E a quali altri film/registi darai voce?
«Il progetto Cinema si collega a quello Rivoluzione. Gli ultimi manifesti che ho realizzato per il centenario erano dedicati a registi delle avanguardie sovietiche, come Dziga Vertov e Lev Kulešov, veri e propri innovatori del cinema. Poi ho iniziato a dipingere locandine di film italiani, iniziando con Caligari, il quale, anche se ha fatto parte di collettivi d’avanguardia, non si può definire un regista rigorosamente d’avanguardia. Nei suoi film, L’odore della notte, Amore tossico e Non esser cattivo, la componente narrativa è fondamentale. Di Caligari mi piace il suo modo di rappresentare, in chiave contemporanea, i problemi del proletariato e del sottoproletariato. La realizzazione di locandine dei suoi film cult, che hanno avuto un’ampia distribuzione, mi serviva per annunciare il mio nuovo progetto e per far capire che le tematiche, trattate nel progetto Rivoluzione, sarebbero state presenti anche in questa nuova serie di manifesti. Sono entrato nel vivo del progetto Cinema quando ho iniziato a dipingere manifesti di film, per i quali non erano mai state realizzate locandine pubblicitarie. Sono nate così le mie opere dedicate ai registi dell’underground italiano, come Alberto Grifi, Romano Scavolini, Nico D’Alessandria, Lajolo-Lombardi-Leonardi (Collettivo Videobase). Una buona parte del cinema d’avanguardia italiano degli anni ‘70 ha dato voce alle contestazioni politiche dell’epoca, offrendo un immaginario nuovo sia dal punto di vista artistico che politico. Dipingere locandine di film d’avanguardia è un buon modo per comunicare contenuti politici e per suscitare, allo stesso tempo, la curiosità nei confronti di un cinema sperimentale, che rischia di cadere nell’oblio. Per il futuro ho intenzione di realizzare manifesti di pellicole di Alfredo Leonardi, Piero Bargellini, Massimo Bacigalupo, Paolo Brunatto ed altri».
Articolo pubblicato su Roma Italia Lab


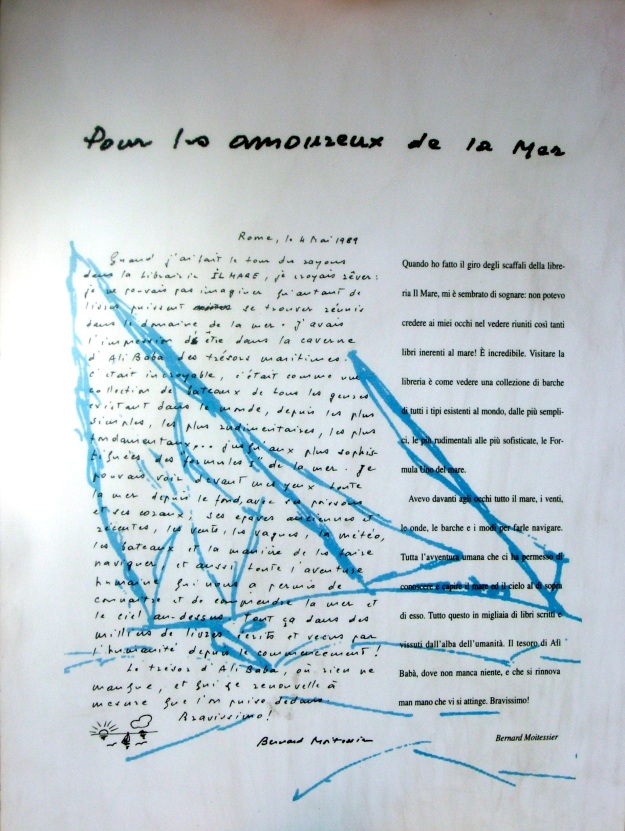
 Ci parla da una fattoria messicana, la giornata di lavoro deve ancora iniziare, lei lavorerà ma senza esagerare perché è incinta della terza figlia. Evelyn è partita per gli Stati Uniti giovanissima e vi è rimasta dieci anni, un lungo periodo di vita clandestina in cui si guadagnava da vivere tra ristoranti e fattorie. Ed è in territorio Usa che si è fatta numerosi tatuaggi perché le piacevano e perché lì era la moda: fiori colorati sulle spalle e sui fianchi e i nomi delle sue bambine. Ma un giorno una collega la denuncia, sa che Evelyn non ha i documenti in regola e le fa pagare una lite con una telefonata alla polizia che la porterà in un centro di detenzione per migranti. “Non saprei dire quanto ci sono rimasta, mi hanno liberato perché avevo una bambina a carico” racconta Evelyn. Poi alla scarcerazione è seguito la deportazione in Honduras, il Paese dove era nata. L’Honduras è al primo posto, nel mondo, per il numero di omicidi: 57,3 persone ogni 100mila abitanti muoiono di morte violenta. La media nel resto del pianeta è 6,2. La ragazza era ospite della sorella a San Pedro Sula, non lontano dal confine guatemalteco, ma dopo soli cinque giorni è stata rapita. “Ero in un negozio, sono arrivati due uomini, mi hanno sollevato e caricato su una macchina, all’inizio non capivo, mi tempestavano di domande sui miei tatuaggi”. Le maras del Centro America – le più importanti sono la Pandilla Barrio 18 e la Mara Savatrucha MS 13 – usano i tatuaggi come segno distintivo e di appartenenza, ogni disegno ha un significato legato all’iniziazione o alle attività criminali e i capi possono tatuarsi anche il volto. “I miei tatuaggi li disorientavano, alcuni avevano colori appartenenti a maras nemiche, ad un certo punto hanno pensato che fossi la donna di più capi allo stesso momento”. Durante il sequestro Evelyn ha subito diverse forme di violenza che non vuole ricordare, “continuavano a chiedermi il significato dei miei tatuaggi e mi ripetevano: ‘possibile che nessuno ti abbia spiegato che non puoi avere questi colori insieme?’”. Poi è stata liberata: “non so perché, se io li abbia convinti delle mia totale estraneità da quel mondo, se lo abbia voluto Dio o se li ho impietositi parlandogli delle mie bambine”.
Ci parla da una fattoria messicana, la giornata di lavoro deve ancora iniziare, lei lavorerà ma senza esagerare perché è incinta della terza figlia. Evelyn è partita per gli Stati Uniti giovanissima e vi è rimasta dieci anni, un lungo periodo di vita clandestina in cui si guadagnava da vivere tra ristoranti e fattorie. Ed è in territorio Usa che si è fatta numerosi tatuaggi perché le piacevano e perché lì era la moda: fiori colorati sulle spalle e sui fianchi e i nomi delle sue bambine. Ma un giorno una collega la denuncia, sa che Evelyn non ha i documenti in regola e le fa pagare una lite con una telefonata alla polizia che la porterà in un centro di detenzione per migranti. “Non saprei dire quanto ci sono rimasta, mi hanno liberato perché avevo una bambina a carico” racconta Evelyn. Poi alla scarcerazione è seguito la deportazione in Honduras, il Paese dove era nata. L’Honduras è al primo posto, nel mondo, per il numero di omicidi: 57,3 persone ogni 100mila abitanti muoiono di morte violenta. La media nel resto del pianeta è 6,2. La ragazza era ospite della sorella a San Pedro Sula, non lontano dal confine guatemalteco, ma dopo soli cinque giorni è stata rapita. “Ero in un negozio, sono arrivati due uomini, mi hanno sollevato e caricato su una macchina, all’inizio non capivo, mi tempestavano di domande sui miei tatuaggi”. Le maras del Centro America – le più importanti sono la Pandilla Barrio 18 e la Mara Savatrucha MS 13 – usano i tatuaggi come segno distintivo e di appartenenza, ogni disegno ha un significato legato all’iniziazione o alle attività criminali e i capi possono tatuarsi anche il volto. “I miei tatuaggi li disorientavano, alcuni avevano colori appartenenti a maras nemiche, ad un certo punto hanno pensato che fossi la donna di più capi allo stesso momento”. Durante il sequestro Evelyn ha subito diverse forme di violenza che non vuole ricordare, “continuavano a chiedermi il significato dei miei tatuaggi e mi ripetevano: ‘possibile che nessuno ti abbia spiegato che non puoi avere questi colori insieme?’”. Poi è stata liberata: “non so perché, se io li abbia convinti delle mia totale estraneità da quel mondo, se lo abbia voluto Dio o se li ho impietositi parlandogli delle mie bambine”. Resistere. Dopo il pranzo, un veloce caffè e si torna a lavoro. È il triste destino di quasi tutti i lavoratori e da oggi anche l’ultimo baluardo dei pisolatori rischia il crollo: gli spagnoli potrebbero dover rinunciare alla “siesta”, la dormita legalizzata che consente ai cittadini iberici di fare una lunga pausa: dalle 14 fino alle 16 o addirittura le 17. Lo ha deciso Rajoy, primo ministro spagnolo, che sembra voler dare un ultimo colpo di reni alla produttività del suo Paese, ci aveva già provato nel 2013 ma il progetto era fallito e questa volta il premier conta di trovare consenso facendo leva non tanto sulla sete di profitto quanto sulla logica: riducendo la pausa si anticipa anche l’uscita dall’ufficio. Eppure non è detto che gli spagnoli ci caschino perché ormai in tutto il mondo la siesta si è scrollata di dosso l’immagine della pelandrona per diventare la migliore alleata della creatività e dei fatturati in crescita da Nike a Google. Già alcune categorie erano state richiamate all’ordine in nome dell’efficienza: Zapatero aveva accorciato il pranzo di chi lavora nell’amministrazione. E aveva ricevuto gli applausi della Confindustria spagnola secondo la quale l’8% del pil andava in fumo per colpa della siesta. La Spagna deve cambiare passo e la rivoluzione non è solo per chi timbra il cartellino, Rajoy vuole stravolgere anche il fuso orario. O meglio normalizzarlo al “tempo medio di Greenwich” perché Madrid è tarata sull’orario di Berlino, una decisione ormai fuori tempo visto che fu presa da Franco nel 1942 in omaggio ad Hitler. L’eccessivo calore delle ore centrali della giornata è, nell’immaginario comune, la giustificazione dei popoli meridionali, mediterranei e latini, per chiudere gli occhi, abbassare il sombrero, rilassare le membra e “ronfare”. La siesta è un’abitudine che fa rima con un certo senso di svogliatezza e diventa vezzo geniale solo quando si associa al potere politico o all’estro artistico. Da Bonaparte a Churchill che dormivano tra il primo e il secondo tempo delle battaglie. Anche in sella al cavallo. Fino a Clinton e Thatcher e ai sonnellini lampo dichiarati da Berlusconi. I micro-sonni d’altronde sono obbligatori per i navigatori solitari che solcano gli Oceani e non possono concedersi di mollare la barra del timone. La creazione artistica è un’altra valida giustificazione, Salvador Dalì si distendeva su una chaise longue e dipingeva le immagini sognate. E in qualche caso un neofita dell’arte potrebbe giurare che avesse mangiato un po’ pesante. O Albert Einstein che si appisolava impugnando una penna per svegliarsi quando gli cadeva di mano. I comuni mortali però se si appoggiano un attimo sul divano sono solo dei pigroni scansafatiche.
Resistere. Dopo il pranzo, un veloce caffè e si torna a lavoro. È il triste destino di quasi tutti i lavoratori e da oggi anche l’ultimo baluardo dei pisolatori rischia il crollo: gli spagnoli potrebbero dover rinunciare alla “siesta”, la dormita legalizzata che consente ai cittadini iberici di fare una lunga pausa: dalle 14 fino alle 16 o addirittura le 17. Lo ha deciso Rajoy, primo ministro spagnolo, che sembra voler dare un ultimo colpo di reni alla produttività del suo Paese, ci aveva già provato nel 2013 ma il progetto era fallito e questa volta il premier conta di trovare consenso facendo leva non tanto sulla sete di profitto quanto sulla logica: riducendo la pausa si anticipa anche l’uscita dall’ufficio. Eppure non è detto che gli spagnoli ci caschino perché ormai in tutto il mondo la siesta si è scrollata di dosso l’immagine della pelandrona per diventare la migliore alleata della creatività e dei fatturati in crescita da Nike a Google. Già alcune categorie erano state richiamate all’ordine in nome dell’efficienza: Zapatero aveva accorciato il pranzo di chi lavora nell’amministrazione. E aveva ricevuto gli applausi della Confindustria spagnola secondo la quale l’8% del pil andava in fumo per colpa della siesta. La Spagna deve cambiare passo e la rivoluzione non è solo per chi timbra il cartellino, Rajoy vuole stravolgere anche il fuso orario. O meglio normalizzarlo al “tempo medio di Greenwich” perché Madrid è tarata sull’orario di Berlino, una decisione ormai fuori tempo visto che fu presa da Franco nel 1942 in omaggio ad Hitler. L’eccessivo calore delle ore centrali della giornata è, nell’immaginario comune, la giustificazione dei popoli meridionali, mediterranei e latini, per chiudere gli occhi, abbassare il sombrero, rilassare le membra e “ronfare”. La siesta è un’abitudine che fa rima con un certo senso di svogliatezza e diventa vezzo geniale solo quando si associa al potere politico o all’estro artistico. Da Bonaparte a Churchill che dormivano tra il primo e il secondo tempo delle battaglie. Anche in sella al cavallo. Fino a Clinton e Thatcher e ai sonnellini lampo dichiarati da Berlusconi. I micro-sonni d’altronde sono obbligatori per i navigatori solitari che solcano gli Oceani e non possono concedersi di mollare la barra del timone. La creazione artistica è un’altra valida giustificazione, Salvador Dalì si distendeva su una chaise longue e dipingeva le immagini sognate. E in qualche caso un neofita dell’arte potrebbe giurare che avesse mangiato un po’ pesante. O Albert Einstein che si appisolava impugnando una penna per svegliarsi quando gli cadeva di mano. I comuni mortali però se si appoggiano un attimo sul divano sono solo dei pigroni scansafatiche.





























